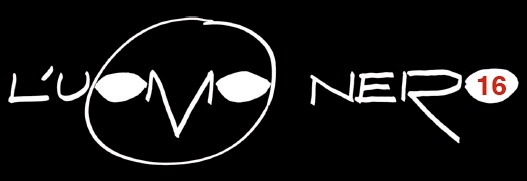 Materiali per una storia delle arti della modernità anno XVI, n. 16
novembre 2019
|
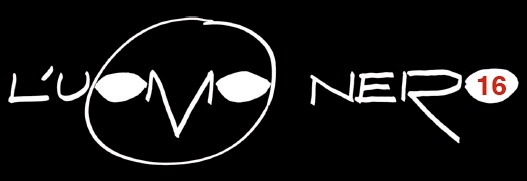 Materiali per una storia delle arti della modernità anno XVI, n. 16
novembre 2019
|
L’Uomo Nero International Editoriale di Davide Colombo |
Al di là dei saggi dedicati ad artisti, mostre o riviste di respiro internazionale che periodicamente sono stati pubblicati nei numeri precedenti, è la seconda volta che “L’uomo nero” propone un affondo più circostanziato sulle ricerche artistiche sviluppatesi in contesti territoriali e nazionali differenti. La prima volta, affrontando, con L’uomo nero GTX, decimo numero della rivista (2013), il tema del viaggio: viaggi di opere, di artisti, di immagini e di testi; viaggi reali o viaggi immaginari; viaggi solitari o collettivi. Ora assumendo la parola “internazionale” come oggetto di riflessione, non tanto come categoria monolitica, quale non può essere, ma nelle più diverse accezioni che questo termine può assumere. Del resto nel corso della storia e nella tradizione della letteratura artistica troviamo moltissimi casi in cui l’aggettivo “internazionale” accompagna sostantivi quali “arte”, “artista”, “esposizione”, “rivista”, “fortuna”, “critica”, “associazione” o “società”. In un’esemplificazione necessariamente sommaria e, forse, anche arbitraria si potrebbe partire dalle Esposizioni Universali, alle quali è dedicata la copertina di questo numero de “L’uomo nero”, attraverso un confronto tra una elaborazione grafica e l’originale dell’affiche di Jean Carlu per l’Exposition Internationale di Parigi del 1937, in cui il profilo della Marianne si staglia su una parete di bandiere delle nazioni partecipanti. Dopo la Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations di Londra (1851) e la Exhibition of the Industry of All Nations di New York (1853), con l’Exposition universelle des produits de l’agriculture, de l’industrie et des beaux-arts di Parigi (1855), che vide la partecipazione di artisti di ventotto nazioni, l’arte divenne sempre più un elemento ricorrente e costitutivo della complessiva offerta merceologica delle grandi esposizioni universali successive. Ma come non pensare alla più famosa delle esposizioni internazionali, la Biennale di Venezia, nata nel 1895 con la dicitura I Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia e con il preciso obiettivo di aprire il panorama artistico italiano a un contesto più ampio e mettere la città lagunare al centro dell’attenzione del mondo dell’arte. Fin da subito fu indicata nella “internazionalità” la caratteristica del progetto espositivo, tanto da prevedere una parità di inviti ad artisti italiani e stranieri. Una vocazione che decretò l’immediato successo dell’esposizione e che si concretizzò ancor più con la costruzione dei padiglioni nazionali ai Giardini di Castello, a partire da quello del Belgio realizzato nel 1907. È una formula che continua a funzionare visto il numero crescente di nazioni partecipanti – fino a raggiungere gli 89 paesi per la 58a edizione del 2019 –, nonostante i primi tentativi di riformulazione del 1968 con la proposta di abolizione dei padiglioni nazionali e le trasformazioni socio-politiche degli ultimi trent’anni, quando la caduta del muro di Berlino e la globalizzazione prima, l’epoca digitale poi, hanno fatto pensare (erroneamente) a un superamento di questo sistema, quasi non fosse più necessaria un’identificazione nazionale. L’internazionalità è un aspetto centrale anche di certi movimenti e tendenze artistiche che hanno avuto un intrinseco carattere transnazionale, parallelamente a un assetto fluido e, spesso, inclusivo. Dopo la prima mostra collettiva del 1925, durante gli anni Trenta il surrealismo si aprì sempre più internazionalmente: si susseguirono l’International Surrealist Exhibition organizzata da André Breton alle New Burlington Galleries di Londra nel 1936 e, soprattutto, la famosa Exposition Internationale du Surréalism, tenutasi presso la Galérie Beaux-Arts di Parigi nel gennaio-febbraio del 1938. Una mostra che, grazie all’impostazione voluta da Breton e all’allestimento di Marcel Duchamp, si trasformò in una vera creazione artistica collettiva, con un radicale ripensamento della tipologia dell’esposizione d’arte e della stessa nozione corrente di arte, avvicinandosi alla Erste Internationale Dada-Messe del 1920 a Berlino, che ricalcava programmaticamente il carattere di una fiera. Allo stesso modo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche fenomeni quali il Situazionismo o Fluxus – caratterizzato dalla radicalità e interdisciplinarietà delle sue pratiche artistiche – si connotarono come “movimento” e come “atteggiamento”, dando vita a una rete internazionale di artisti, musicisti, designer e performer nel corso di trent’anni. Nel secondo dopoguerra la costituzione di nuovi rapporti di forza tra i centri dell’arte, tra Europa e Stati Uniti, si fondò su un’aspirazione internazionale, sulla possibilità di costruire ponti tra nazioni. È una prospettiva che, invece, a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta non resse al cambiamento dei tempi e sembrarono prendere forza, spinte e posizioni transnazionali che trascendessero le appartenenze nazionali in nome di una dimensione apolide e nomade, di collaborazioni e confronti tra gli artisti. Sebbene oggi transnazionale venga usato anche come sinonimo di globale, che tuttavia ha preso il sopravvento, in realtà lo spirito alla base dei due termini porta con sé differenze ideologiche intrinseche. In tempi di “globalizzazione”, la caratura internazionale è la cartina tornasole della fortuna critica, espositiva e commerciale di un artista. Così come l’internazionalizzazione è ormai una realtà, ma anche una necessità e un “dogma” nel mondo accademico. Dell’“internazionale”, quindi, non si può fare a meno. Tuttavia si possono comprendere le differenze tra “internazionale” e “globale”. Certamente, oggi, il primo è un termine meno problematico del secondo (forse perché svuotato di alcune implicazioni originarie). Ma, comunque ricco di accezioni e sfumature differenti. In questo numero della rivista, infatti, gli autori propongono approfondimenti su artisti non italiani, ma anche su situazioni che coinvolgono nazioni diverse e ridiscutono le geografie artistiche, nonché su temi che toccano l’idea di “forestiero” o di “straniero”, in un arco cronologico che parte dagli anni Ottanta dell’Ottocento e arriva ai giorni nostri, con una particolare concentrazione sul secondo Novecento. Senza la volontà di esaurire una complessità terminologica, il confronto di proposte differenti – per temi, punti di vista e approcci metodologici – permette di dare corpo, anche in una riflessione storico-critica sulle ricerche artistiche, al significato costitutivo del termine “internazionale”, dato proprio dal prefisso “inter” (“tra”): la relazione. E di conseguenza, si assolve anche alla funzione di una rivista come “L’uomo nero”, cioè aprire prospettive, mettere in circolo riflessioni, favorire interscambi. Il termine “internazionale” è coniato sull’esempio dell’inglese international, proposto per la prima volta dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham nel libro An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (redatto nel 1780 e pubblicato nel 1789) e associato alla parola jurisprudence, per sostituire il concetto di “legge di nazioni” con quello di “legge tra nazioni”. Se torniamo, infatti, per un momento, al significato letterale dell’aggettivo “internazionale”, vediamo che l’accento si pone su ciò che accomuna, su ciò che circola, su ciò che si estende all’altro. Internazionale è ciò che sta tra nazione e nazione; che concerne le relazioni fra più nazioni e tra le persone di tali nazioni; ciò che interessa, è comune e appartiene a più nazioni; che si estende ad altre nazioni; che è dato dalla partecipazione di più nazioni e verso cui tendono cittadini di varie nazioni. Il tema delle relazioni, del movimento, dello scambio è al centro di molti dei saggi qui proposti. Ma il termine “internazionale” mette in gioco, più o meno inevitabilmente, quello di “straniero”. Ed è proprio con questo tema che si apre e si chiude la sezione tematica de “L’uomo nero”. Il saggio di Julie Rateau-Holbach sulla Exposition Internationale de Peinture et de Sculpture (1882-87) e quello di Paola Valenti sulla Black Diaspora di John Akomfrah affrontano il tema dello “straniero” a partire dalle specifiche contingenze storiche, sociali e politiche, che ne differenziano il significato. Julie Rateau-Holbach ricostruisce le prime sei edizioni (1882-87) della Exposition Internationale de Peinture et de Sculpture che Georges Petit organizzò nella propria galleria con l’iniziale ma fondamentale collaborazione di Giuseppe De Nittis (a cui viene riconosciuto un ruolo centrale), Alfred Stevens e Raimundo De Madrazo, pittori stranieri residenti a Parigi. Il contesto parigino – fatto di artisti che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, giungono nella capitale francese per un viaggio di formazione e aggiornamento, che ha ripercussioni anche nei paesi d’origine attraverso percorsi à rebours – spinse gli organizzatori a pensare a una mostra collettiva che coinvolgesse, soprattutto, artisti stranieri. Qui con “internazionale” si intende “straniero” che vive a Parigi, che assimila la cultura artistica del paese ospitante, ma che favorisce rapporti di scambio con la terra d’origine e vi attiva un processo di disseminazione. Come non ricordare, infatti, i soggiorni parigini da parte di artisti italiani che dalla metà del secolo riportano in patria suggestioni, idee e influenze? Sono i resoconti di De Tivoli, Altamura e Morelli della visita all’Esposizione Universale di Parigi del 1855 e sulla pittura di Delacroix, Corot, Millet, Courbet e della Scuola di Barbizon che accendono le discussioni al Caffè Michelangiolo di Firenze, dove si ritrovano i pittori “di macchia”. Sono il viaggio a Parigi del Piccio nel 1845, quando studia la pittura di Delacroix e della Scuola di Barbizon, o la visita di Antonio Fontanesi sempre all’Esposizione Universale del 1855 dove si interessa alla pittura di Corot e dei barbizoniers, ad avere significative ricadute sulla pittura di paesaggio lombarda e piemontese. Così come altrettanto determinanti furono i soggiorni in Francia dei fratelli Giuseppe e Filippo Palizzi, e di Telemaco Signorini. Rateau-Holbach evidenzia però come a seguito dell’edizione del 1885, caratterizzata dall’introduzione della pittura impressionista, e di quella del 1886, che vede dei cambiamenti nella strategia di Petit, il numero degli artisti francesi crebbe rapidamente fino a diventare maggioritario, modificando le finalità stesse dell’Exposition Internationale. Alla direttrice Italia-Francia se ne aggiungono altre nel saggio di Nicol Mocchi, che individua con acume fonti visive e modelli internazionali nella pittura di Gaetano Previati, cui da tempo è stato riconosciuto il ruolo di protagonista del simbolismo europeo. Certe invenzioni pittoriche della seconda metà degli anni Ottanta, infatti, si possono spiegare solo considerando modelli internazionali tardo-romantici, simbolisti e preraffaelliti di area francese, anglo-americana e svizzero-tedesca acquisiti attraverso la circolazione sulle pagine di riviste e periodici. L’aggiornamento di Previati si fonda su opere poco note in Italia ma al centro del dibattito internazionale e solamente sulla selezione degli elementi più congeniali alla sua ricerca rivolta agli aspetti psicologico-espressivi. Sempre all’interno di una riflessione sugli scambi internazionali – con una particolare attenzione all’Italia – si collocano i tre saggi successivi che danno il via al blocco numericamente maggiore della sezione tematica di questo numero de “L’uomo nero”, che si concentra cronologicamente sulla seconda metà del Novecento. Il contributo di Matteo Bertelé sulla fortuna internazionale di Renato Guttuso nell’Europa socialista degli anni Cinquanta apre la riflessione a prospettive e implicazioni di carattere politico, mettendo in discussione uno sguardo erroneamente troppo monolitico sul dibattito artistico nell’Europa sotto l’influenza sovietica e svelando una pluralità di posizioni. Il saggio si inserisce all’interno di una nuova attenzione per la figura di Guttuso che si è registrata negli ultimi anni, grazie a una serie di iniziative espositive e di ricerca, tra cui ricordiamo il testo di Chiara Perin su La battaglia di ponte dell’Ammiraglio (1951-52), il primo quadro di storia dell’artista, pubblicato nel n. 13 del 2016 de “L’uomo nero”. Bertelé osserva come la fortuna critica di Guttuso in Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e nella Repubblica Democratica Tedesca a partire dal 1948 – a differenza del ritardo con cui la sua pittura verrà accolta con favore in Unione Sovietica – fosse dovuta alla sua attività di militante politico, critico e artista e all’accoglienza della sua opera come elemento pittorico innovatore e valida alternativa al realismo socialista di retaggio stalinista, alimentando le rivendicazioni di un affrancamento dai dettami sovietici. Nonostante la sua crescente presenza sulla stampa generalista, solo a partire dal 1958 la critica sovietica avviò un processo di valorizzazione del lavoro di Guttuso – grazie all’apparentamento al successo del neorealismo cinematografico – che fu coronato dalla prima personale in Urss nel 1961, che vide una certa indulgenza nei confronti degli aspetti formali della sua pittura. Implicazioni di carattere politico-culturale emergono anche nel saggio di Giovanni Rubino che, analizzando le pagine della rivista “Čovjek i Prostor” (1954-61), passa in rassegna la realtà artistica croata prima della ben nota esperienza di “nove tendencije” tenutasi a Zagabria negli anni Sessanta. Rubino riconosce nel panorama degli anni Cinquanta, oscillante tra una cultura transnazionale jugoslava e quella nazionale croata, la nascita di quell’ideologia artistica internazionale alla base di “nove tendencije”. La rivista “Čovjek i Prostor” fu un laboratorio di ricezione e rielaborazione di fonti visive e testuali dei nuovi fermenti artistici sviluppatisi in Italia, Francia e Germania, intervenendo direttamente nel coevo dibattito interno sul realismo sociale e sull’arte astratta. La rivista godeva di un clima di liberalità politica a Zagabria che avrebbe condotto all’integrazione di “nove tendencije” in un preciso piano culturale condiviso tra l’establishment politico e quello intellettuale. Irene Caravita concentra l’attenzione su un ciclo di “fotografie morbide” realizzate tra il 1969 e il 1970 dagli svizzeri Markus Raetz e Balthasar Burkhard, noto soprattutto per la sua collaborazione con Harald Szeemann e per le sue fotografie delle esposizioni When Attitudes Become Form (1969) e Documenta 5 (1972). Si tratta di fotografie di ambienti domestici stampate in bianco e nero su tele emulsionate di grandi dimensioni appese con due o più ganci alla parete, precocemente esposte anche in Italia alla Galleria Diagramma di Luciano Inga-Pin nel marzo del 1971 e recensite su “Domus” il mese seguente. Accanto alla ricostruzione delle vicende espositive e della doppia paternità dell’opera (spesso venuta meno nella bibliografia inerente), Caravita affronta le caratteristiche salienti di queste fotografie – intese come oggetti scultorei veri e propri – che mettono in gioco temi centrali della ricerca fotografica e artistica di quegli anni: la tridimensionalità oggettuale restituita alla fotografia bidimensionale, l’effetto realistico o addirittura iperrealistico, quasi da trompe-l’oeil, l’allestimento di tipo installativo e gli squilibri percettivi suscitati nello spettatore. A conclusione della sezione tematica, il saggio di Paola Valenti analizza il tema dello “straniero” nel lavoro di John Akomfrah, artista di origini ghanesi emigrato a Londra all’età di nove anni, a partire dalla sua attività con il Black Audio Film Collective, attivo tra il 1982 e il 1998 in ambito artistico, cinematografico e televisivo, per concentrarsi su alcuni lavori video recenti: The Nine Muses (2010), Peripeteia (2012), Tropikos (2015), Vertigo Sea (2015), Auto Da Fé (2016). Akomfrah affronta un tema di cui egli stesso è partecipe, la condizione dello “straniero”, nella duplice accezione di qualcuno che viene da un luogo altro e di qualcuno che è sconosciuto, non familiare. Si tratta di una riflessione sull’identità dei migranti e sulla loro appartenenza culturale, sociale e politica ai paesi d’approdo, nonché sul tema della memoria e dell’oblio. La seconda parte – Fuori tema – dell’“Uomo nero” presenta una proposta di lettura di Stefano Agresti su due nuclei di opere di Enrico Castellani realizzati nel 1956 e nel 1960, attraverso i quali comprendere il passaggio della ricerca dell’artista da un linguaggio più gestuale e informale a quello delle Superfici a rilievo, date dall’alternarsi ritmico e strutturato delle introflessioni ed estroflessioni della tela monocroma. Agresti sottolinea come in questo passaggio giochi un ruolo centrale una nuova idea di temporalità in cui ogni residuo soggettivo viene eliminato. Segue, nella sezione Arte Pubblica, un saggio di Michele Gentili su Maria Lai, artista che negli ultimissimi anni ha ricevuto il giusto riconoscimento grazie alla 57a Biennale di Venezia (2017), a Documenta 14 (2017) e ad alcune ricche mostre retrospettive a Cagliari, a Firenze e a Roma. Della Lai, l’autore ricostruisce con grande attenzione le vicende relative a La disfatta dei varani, un progetto ideato per la città di Camerino tra il 1983 e il 1984, ma mai realizzato secondo le modalità indicate dall’artista stessa. Una corretta rilettura delle fonti dell’epoca ha permesso all’autore di chiarire alcuni equivoci e di agevolare la comprensione della portata innovativa e poetica di questo intervento di carattere pubblico. Chiude il numero, la parte dedicata a Rarità, scoperte e segnalazioni, con gli articoli di Marco Cavenago e Anna Contro. Cavenago propone la riscoperta di un rimarchevole gruppo di sculture facenti parte della cappella Negroni Prati Morosini a Pessano, piccola località del Milanese, che comprende opere inedite di Amalia Duprè, Pompeo Marchesi e Vincenzo Vela realizzate tra gli anni Trenta e Ottanta dell’Ottocento. Anna Contro pubblica il carteggio inedito tra Giorgio Nicodemi e Alessandro Mazzucotelli conservato presso l’Archivio privato della famiglia Nicodemi: ventiquattro, tra lettere e cartoline, scritte tra il 1923 e il 1928 – anni in cui Nicodemi è direttore dei Musei civici di Brescia –, da cui emerge una fitta rete di relazioni con artisti, critici e intellettuali, utile a comprendere il sostrato politico-culturale del periodo e ad acquisire ulteriori indicazioni sul successivo ingresso di Nicodemi nei musei milanesi. |
| indice | |